Submitted by admin on
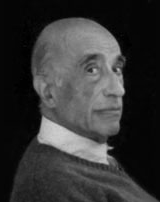
Claudio Varese
L’ampio saggio di Claudio Varese (1909-2002) del 1951 segna l’inizio di una nuova e fortunata interpretazione dell’opera panziniana. Infatti, parallela alla denigrazione assoluta della scuola critica marxista, si svilupperà la rilettura, sociologica prima ancora che letteraria, del suo lavoro come “documento della cultura e del costume” della società italiana del primo Novecento.
La fortuna editoriale del Panzini, secondo Varese, si deve alla sua contiguità psicologica e morale con l’italiano piccolo borghese, il quale vedeva crollare, sotto il peso degli sconvolgimenti economici, culturali e politici del mondo moderno, tutte le sue certezze. Una classe che per questo si sentiva estranea al suo tempo, spettatrice impotente della fine del proprio mondo, che inconsciamente credeva eterno. Questa indole di testimone passivo fa si che il commento, l’analisi e l’annotazione, attraverso cui Panzini manifesta il suo disgusto nei confronti di una realtà meschina ed intollerabile, siano le forme predominanti della sua narrativa. La letteratura costituisce per Panzini, che Varese non a caso definisce “umanistico postillatore della vita”, l’estremo argine per proteggersi dalla volgarità della modernità.
“L’opera di Alfredo Panzini non va considerata soltanto nel suo valore artistico, ma insieme come documento della cultura e del costume italiano. La letteratura, il culto delle umane lettere, l’abitudine a pensare, richiamandosi continuamente alla scuola e ai classici, in un giuoco continuo di confronti, accompagnano sempre lo scrittore: per certi aspetti, il Panzini può venire considerato come un rappresentante della mentalità della piccola borghesia umanistica italiana; l’atteggiamento morale e la psicologia dell’autore risentono dei limiti di quella cultura, e nei momenti peggiori si rispecchiano nel temperamento e nella individualità dell’uomo i difetti di tutta una classe. Nelle pagine felici, nel suo valore artistico, il Panzini, come ogni vero poeta, comunque si sia formato, non rappresenta che valori artistici, e non può esser risolta nei suoi termini storici, se non per essere meglio inteso. Ma la sua opera ha anche un significato politico e storico, perché egli ha osato confessare e ha voluto allargare, i dubbi e le incertezze che incrinavano la vita sociale e civile, culturale e morale dell’Italia: con le sue pagine di continua postilla, dal 1894 al 1937, ha commentato la vita italiana; molti scrittori, come molti uomini politici si rinchiudono dentro un’epoca in cui è fiorito il meglio della loro vita, come quelle donne, che essendo state una volta belle ed eleganti, insistono in una certa acconciatura, in una certa pettinatura, credendo così di continuare se stesse: e il Panzini, sebbene provenga non solo dalla scuola del Carducci, ma anche da quella che potremmo chiamare civiltà carducciana, ha saputo adottare i suoi commenti ai vari periodi, con il duttile spirito di un contemporaneo; anzi, il biasimo e il rimbrottio con il quale colpisce le mode e le tendenze, si esprimono in una forma letteraria e morale, che proprio di quelle e di quelle tendenze viene a partecipare. Se è da intendere con cautela, la derivazione dal Carducci scrittore e letterato, meglio si giustifica la derivazione dal Carducci uomo politico, dal Carducci uomo. Vi era nel Carducci il germe di quello scetticismo, che verrà poi a svilupparsi nel Panzini, come del resto il Panzini stesso ci racconta e dimostra nel suo saggio sopra l’evoluzione politica dalla repubblica alla monarchia, e si addentra nello stesso tempo nell’intreccio, si potrebbe dire, di tutti i problemi politici, economici, sociali, morali, contemporanei. Il Carducci vi appare come figura ideale: la cultura classica, latina, greca e italiana, il culto degli eroi, il disprezzo per la moltitudine, l’orgoglio di una dignità morale fatta della coscienza di questo disprezzo, l’aborrimento del lusso e della vita economica, l’insofferenza tipicamente carducciana per l’arte contemporanea, per il teatro, per il mondo contemporaneo, vengano esaltate a legge.
Il Panzini porta in se la nostalgia di due mondi fra di loro nemici, amati da lui dell’amore che si ha per il passato, dove anche i contrasti più facilmente si conciliano, il mondo tradizionale e cattolico della vita patriarcale, e il mondo del partito repubblicano storico. Il Panzini delinea una forma di repubblicanesimo classico, aristocratico, che può armonizzare con le forme ideali della virtù, della patria e della religione; di questi repubblicani classici il Panzini parlerà ancora volentieri nel Libro dei morti, ed esaltandoli, nella Vera istoria dei tre colori. Dal fastidio carducciano per la vil maggioranza, il Panzini deduce anche un atteggiamento politico, con il suo presente buon senso letterario. Il mondo moderno è un mondo gretto e corrotto, piccolo nelle idee e materiale e meschino nelle aspirazioni. Come il Carducci, anche il Panzini pensa però che questo mondo positivo, questo mondo piccolo e senza ideali, è il vero mondo del presente e ancor più dell’avvenire: il Carducci lo riconosce, ma se ne sdegna e vi tempesta contro; il Panzini invece vela il suo sdegno di quella malinconia e di quella amarezza riflessiva e ripiegata, che sarà poi sua caratteristica. Veramente, dal Carducci Panzini ha imparato il senso un po’ astratto dell’ideale e immobile perfezione della vita, una concezione politica apparentemente profonda e comprensiva, ma in realtà ingenua, un atteggiamento di sfiducia, di diffidenza e insieme di rassegnazione verso la vita contemporanea. Da questo, i due motivi che risuoneranno spesso e a lungo nell’opera panziniana, lo sgomento per l’intensità della vita economica contemporanea, il rimpianto per la serena, per l’aurea mediocrità della vita del passato.
[…] Di questa tendenza a valersi della lingua con tutte le libertà di un romantico, ma nel gioco di una disciplina classica, il Panzini si è sempre dimostrato consapevole: nella tendenza a un suo originale stile maccheronico, egli porta non solo la sua cultura e i suoi amori di letterato, ma anche il suo atteggiamento morale, la curiosità sempre desta di ogni particolare, di ogni fremito, e insieme l’amore e la venerazione, e la confidenza con il mondo classico.
[…] Il primo romanzo del Panzini, Il libro dei morti, deriva la sua ispirazione da questa educazione, da questa cultura del tempo bolognese e, in questo senso, sembra un commento narrativo alla Evoluzione politica di Giosuè Carducci. Anche qui il sentimento di ammirazione per il repubblicanesimo classico ed eroico, rappresentato dal dottore, si esterna con la nostalgia del vecchio mondo, dell’antico regime con il biasimo del nuovo moderno. Le idealità, le care abitudini della vita patriarcali sono minacciate e travolte: le tasse, l’inquietudine di novità, la smania di piaceri e di soddisfazioni malsane e non ragionevoli, minacciano quella semplice vita. Il libro si chiama Il libro dei morti, perché tutto il disteso racconto di questa vita e serena, è inquadrato nel ricordo che ne serba l’anima di Gian Giacomo, semplice e saggio proprietario della campagna di Rimini, il quale vorrebbe, dopo morte, tornare dal figlio e ammonirlo che tutti gli ideali, tutte le speranze di quella vita morale e religiosa, sono false; ma poi vedendo quanto serena, quanto mite e pura è la vita del figlio, il quale crede alla virtù e alla religione, non osa appannarne lo spirito, e si ritira. Questi motivi dell’esaltazione della vita semplice e modesta, che ricorreranno poi in tutta l’opera del Panzini sono qui nella forma più ingenua: «Le tenebre montano, ma il lumicino della Madonna arde come un faro, e la buona madre sorride più dolce in quel raccoglimento silenzioso della sera». L’amarezza dello scetticismo morale, quella polemica contro l’idea del progresso –basta rammentare quel che dirà nel Diario di guerra- è già cominciata in questo libro, anzi è qui naturalmente più esplicita e più ingenua. Il dialogo fra il notaio, che vuole il progresso, il lusso, la ricchezza, la sensualità, e il proprietario agricolo Gian Giacomo, che vuole la serenità, la semplicità, la virtù, la famiglia, ritorna infinite volte nell’opera del Panzini: la ripugnanza e insieme l’accettazione del darwinismo, dell’evoluzionismo, delle forme del positivismo, è entrata nella formazione dello scrittore, il quale vi si fermerà, anche i problemi saranno spostati.
[…] Una tendenza del gusto panziniano, o piuttosto del suo mondo morale, è quella di introdurre e di contrapporre il poetico, il letterario in contrasto con la vita, con la realtà; di questo contrasto è costruita spesso e volentieri la sua opera, non soltanto in senso morale e psicologico, ma anche in senso letterario, come se questa giustapposizione o contrasto corrisponda a una giustapposizione o contrasto di brani e forme poetiche con brani e forme realistici, quotidiani e sciatti.
[…] La critica ha ammirato e amato quella prosa linda e profumata di spigonardo: quella precisione e quella movenza elegante del periodo; dirò di più, che nell’ammirazione di critici come il Cecchi o il Borgese, si rifletteva anche naturalmente il loro gusto e la loro esigenza. Il Cecchi, allora giovanissimo, e già critico molto acuto, ammirava nel Panzini quegli stessi elementi astrattamente presi, che si trovano in lui, la snellezza dei periodi,e, in un certo senso, delle parole, e una certa indulgenza a quel tono crepuscolare, che s’incontra fra gli altri toni nel Panzini. Per questo tono, il Cecchi preferiva fra tutte le Fiabe della virtù, il Padre e il figlio. Questi critici trovarono risolti nel Panzini, soprattutto in questo Panzini, alcuni dei problemi che li tormentavano: il rapporto fra la prosa tradizionale, come poteva esser rappresentata anche dal Carducci, e la prosa contemporanea con le esigenze della modernità; il riflesso della vita contemporanea nella letteratura narrativa e le forme di quella malinconia, di quel senso evasivo di crisi, che era di quella letteratura. D’altra parte, la soluzione che ne dava il Panzini era tale da essere ammirata piuttosto che imitata o biasimata come un’inframmettenza o uno sbaglio.
[…] Il bacio di Lesbia ha una sua facilità letteraria: il Panzini ama la citazione, anzi, la citazione è per lui sempre più elemento essenziale della sua maniera letteraria e libri come questi, La sventurata Irminda gozziana e Il bacio di Lesbia, sono intessuti e appoggiati alle citazioni: l’autore continuamente traduce Catullo ed a Catullo si riferisce. Tutti gli amori e i gusti morali panziniani ritornano in questo libro, dove Catullo sembra in certi momenti lo stesso Panzini e d’altra parte Augusto e Cesare sono idoleggiati con quella simpatia e venerazione per gli eroi che è tanto caratteristica. Le ultime opere del Panzini riflettono, come staccate, i motivi della sua formazione, non soltanto nell’aspetto letterario, ma anche in quello etico. Vengono in mente, per contrasto, le parole estreme, inesatte in sede estetica e letteraria, ma moralmente così calzanti, di Alessandro Manzoni al giovane Coen, desideroso di darsi alle lettere. Quante ci imbattiamo, leggendo questo nostro autore, in quella falsità o piuttosto inconsistenza umana, che un certo modo di studiare le lettere può favorire, in quel passaggio arbitrario e facilmente seducente dalla letteratura alla vita, in quell’abbandono evasivo e nostalgico alle immagini di un passato brillante. I ricordi della letteratura, non solo diventano occasioni di patetica nostalgia, e vagheggiamenti di forme perfette, non solo entrano nell’impasto maccheronico del suo linguaggio, ma diventano l’armatura della sua personalità morale, il contenuto della sua ideologia facilmente conservatrice. In questo senso il Panzini è stato simile al D’Annunzio; e l’uno in tono maggiore, l’altro in tono minore, ma non per questo meno significativo, sono stati espressione e insieme stimolo della crisi del mondo italiano tra l’Ottocento e il Novecento; molti aspetti di larghi ceti colti italiani si riflettono nelle pagine del Panzini, nelle sue diffidenze, nei suoi timori, nella sua mancanza di un’opinione che non sia un risentimento o una nostalgia. Non cattolico, si è sempre compiaciuto, con estetismo sentimentale, della religione cattolica. In Il ritorno di Bertoldo, l’autore, al termine della sua opera, riprende i suoi vecchi motivi: da una parte la letteratura, dall’altra la campagna, quella campagna panziniana, che è un misto di Arcadia e di Folengo. Per spiegare le ragioni del suo amore alla terra, quanti nomi, quante citazioni: gli Idilli di Teocrito, Virgilio, Tetrarca, Esiodo, Ulisse, Kipling, Cicerone; Freud!
Riappaiono in questa conclusione, in questo epilogo un po’ estrinseco, tanti elementi della sua maniera: come il Leopardi nella Canzone ad Angelo Maj vede sfilare i grandi scrittori italiani, così, ma con molta più letteraria intenzione, il Panzini vede passare gli scrittori che dicono le frasi adatte alle circostanze e commentano le situazioni con loro situazioni: l’Ariosto con la sua casetta, il Manzoni con il bel paesaggio della sua giovinezza e la villa paterna sulla riva di quel lago “da cui l’Adda sempre si muove”, e Giovanni Pascoli con la Badia di Pomposa. Ci son dei capitoli che hanno proprio l’aria del vocabolario nomenclatore, di più facile vocabolario: perché, nonostante le citazioni, il Panzini appartiene, come il D’Annunzio, a quegli scrittori che hanno dato agli italiani l’idea di capire delle cose difficili: niente è più pericoloso di una forma che, sembrando difficile, sia in realtà facile, rapida e orecchiabile.
[…] Con i suoi umori, con le sue inclinazioni letterarie e morali, con le sua antipatie e simpatie politiche, egli ha accompagnato le onde che si muovevano alla superficie della vita italiana, di una certa vita italiana. Curzio Malaparte, che ha agitato clamorosamente, non dico gli ideali, ma i motivi dell’Italia saggia, sana, tradizionale, paesana, anzi strapaesana, riconosceva –ed è un riconoscimento molto significativo- questo aspetto del Panzini: nell’Italia barbara si legge: «Quel che fa di Panzini un italiano in sommo grado rappresentativo fra i contemporanei e quasi la maschera della crisi o trasformazione (o commedia) che il nostro comune spirito nazionale oggi attraversa, è appunto questo motivo drammaticissimo dello stupore, il quale assume in lui, attore-tipo, gli aspetti più diversi e significativi ….. »
- Log in to post comments