Submitted by admin on
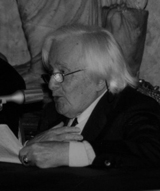
Carlo Muscetta
Carlo Muscetta (1912-2004) riprende direttamente il discorso e i toni di Antonio Gramsci. L’astio del Muscetta, che raggiunge punte di vero e proprio livore, si deve al fatto che, nel dibattito critico del secondo dopoguerra, il significato dell’esperienza panziniana comincia a travalicare il semplice valore artistico, per diventare un simbolo dell’universo morale e intellettuale dell’Italia reazionaria e piccolo-borghese, dalle cui aspirazioni e, soprattutto, paure, ebbe origine il fascismo. Un disprezzo oseremmo dire quasi antropologico.
Muscetta non evita di elencare i sintomi più evidenti, e nefasti, di questa particolare forma-mentis: il ripiegamento impaurito nella sfera privata, il soffocante “provincialismo culturale”, la presa di distanza da ogni seria e rigorosa indagine socio-politica e l’amore calligrafico per la bella scrittura.
Descritto uno scenario così drammatico, Muscetta pensa che solo un’opera di Panzini avrà il potere di salvarsi dal trascorrere del tempo, il Dizionario moderno. Non certo, naturalmente, per i meriti conseguiti nel campo della lessicografia, ma perché resterà «un documento di prim’ordine per la storia intellettuale delle cosiddette “persone colte” nell’Italia novecentesca». Un museo degli orrori di quella cultura reazionaria e baciapile che “ha conformato milioni di cervelli della piccola borghesia”.
“Mentre si va commemorando il Panzini nel decennale della morte, ecco venir quattro pagine dei quaderni di Gramsci dove si incide il rugoso e insieme infantile volto reazionario di questo professor d’umorismo: «nipotino di padre Bresciani».
Il giudizio di Gramsci riguarda soprattutto il Panzini biografo di Cavour, ma illumina di passata anche la sua letteratura, la miserrima qualità del suo atteggiamento sentimentale: «Il Panzini insomma piange perché si fa pena. Piange di se e della morte». È un’osservazione acuta che in nessun critico del Panzini ho ritrovato, nemmeno nel Serra, il quale, nonostante l’affetto per il suo lettore, è così ricco di giudizi negativi. Quante cose egli riuscì vedere agli inizi della carriera letteraria di Panzini: i limiti e i pericoli della sua maniera, l’intelligenza mediocre, «la letteratura buona ma non squisita», l’osservazione e la rappresentazione «nitida ma non potente», la arguzia «spontanea ma un poco scarsa», e persino l’incapacità radicale a trattare di cose storiche. Ma Renato Serra, se era per cultura e per altezza di ingegno non provinciale, partecipava degli stessi limiti di classe del Panzini e ne condivideva certo dilettantismo e la morbosa inclinazione crepuscolare, e quel concetto un po’ retorico e formale del classicismo che era il retaggio comune della scuola carducciana. Non aveva il distacco di una moralità nuova, di una nuova concezione della vita, per rifiutare in partenza questo intenerimento su se stesso che del resto era la fioca vena poetica di Panzini; specie nelle pagine più antiche dove «lo scudiero dei classici» aveva una certa grazia nativa e le stesse goffaggini erano sincere, non divenute ancora stucchevoli e calcolate piroette. C’erano nel primo Panzini certe situazioni liriche, di una piccola anima di poeta che cosciente dei propri limiti e pavida di spiccare il volo si era rassegnata alla prosa (una prosa, checché sia stato detto, più vicina a quella del Pascoli, che non a quella di Carducci; o semmai ai toni minori carducciani, magari di certe lettere o di certi passi autobiografici). Una prosa che ogni tanto latineggiava non senza spocchia di ludimagistro, con l’aria di dire: - Non vero mica che ho preso anch’io la mia cotta per Arrigo Heine e l’ho scoperto con cinquant’anni di ritardo: lasciamogli volentieri gli umori progressisti 1830. Se mai il mio maestro è Orazio. Satyra tota nostra est.
Però si dovrebbe andare adagio a collocarlo senz’altro tra i «classici». E m’è dispiaciuto tanto, caro Pancrazi, che anche tu, sempre così misurato, ti sia lasciato andare a una definizione così imprudente. Ad apertura di libro, anche negli scritti più celebri, eccola questa prosetta grinzosa e imbellettata che ci viene incontro dameggiando e sninfeggiando, con falsi rossori e languori, lusinghevole, vanesia, ora interrogativa, ora sospensiva, più spesso esclamativa e pettoruta della più banale sapienza con cento vezzi e sgarbi improvvisi; ma ammirando un paesaggio o facendo l’occhietto, misurando le cose dall’alto in basso o nell’atto di compatirsi, trova sempre il modo di persuadere il lettore su almeno uno di questi tre punti: 1) lacrimate con l’autore sui suoi patemi: però, dite la verità, che stilista! 2) un pizzico di latino vale più di tutta l’arte e la scienza moderna messa insieme. Nihil sub sole novum. 3) i filosofi da Socrate a Marx a Croce farebbero ridere, se non facessero tanta pena. Solo il buon Dio, anche perché quell’essere appetibile che è la Donna e l’ingegnoso prof. Panzini, solo il buon Dio in fondo è un rispettabile personaggio che un umorista clericale non si azzarda mai di prendere in giro.
Nella ricetta di Panzini questi tre ingredienti sono rituali e costituiscono quello che Gramsci chiamava esattamente il «gesuitismo» o il «brescianesimo» di Panzini. Lo possiamo riscontrare con una costanza impressionante dalle opere prime a quelle della vecchiaia. Dopo di che è chiarissimo che egli dovesse simpatizzare più con Monaldo Leopardi che con Cavour (dei quali ha scritto biografie parimenti mediocri e male informate), e che credesse, come è noto, Giovanni Verga una nullità, appetto del padre Bresciani «potente narratore».
Dal Libro dei Morti alla Lanterna di Diogene ai Giorni del sole e del grano, l’odio per le masse, la paura e la repulsione più che estetica per gli operai in sciopero e i contadini affamati di terra gli traboccavano dal cuore profondo, benché il nostro povero letterato amasse professarsi «puro» e «apolitico». E volete conoscere l’ora eletta in cui egli sentiva la sua solitaria vocazione alla poesia? «La domenica, ad ora ben tarda cessano i canti [dei lavoratori] con sollievo delle Muse, ed i grilli riprendono l’impero della notte serena». Con rara delicatezza s’inteneriva, lui, per i nobili pini abbattuti, per il falco prigioniero, per il cuoricino del passerotto, per le ostriche e per i grilli; ma gli uomini che lavorano, puah! E infatti nel Dizionario moderno si piglierà la briga di registrare una parola tutt’altro che nuova e moderna, al solo di buffoneggiare in siffatti termini: «calli (o callosità delle mani) costituiscono per il proletariato l’emblema della sua nobiltà, il documento del suo diritto alla Dittatura». Da questo fiorellino immaginate quale profumo spanda il dizionario panziniana. Il quale seppure tutte le altre opere (ben facile profezia) saranno seppellite nel dimenticatoio, resterà un documento di prim’ordine per la storia intellettuale delle cosiddette «persone colte» nell’Italia novecentesca.
Le opere di Panzini vanno tramontando a poco a poco. Santippe parve giustamente insopportabile al De Robertis quando si provò a rileggerla, a tanti anni di distanza. Il Bacio di Lesbia oggi ci appare già come uno dei tanti travestimenti dei quali si compiace la fantasia accidiosa dell’autore, con quel suo gusto, accentuatosi nella vecchiaia, di pomicione timorato, amante del buon costume e della pruriginosa licenza. Forse le Fiabe della virtù con la loro non dissimulata unzione cattolica rendono appieno, intimamente, l’immagine vera dello scrittore (Emilio Cecchi non si era ingannato). Ma io credo che solo il Dizionario moderno meriti di restare come un autentico tesoretto nel quale si contiene «tutto quello che sapeva» l’italiano medio nella prima metà del secolo XX. Dal 1905 ha avuto una decina di edizioni ed è stato uno dei libri più diffusi fra i nostri intellettuali. Andate a consultarlo con una certa metodicità e vi accorgerete che tutti i luoghi comuni dell’antiliberalismo e dell’antisocialismo sono altrettanto frequenti in ogni pagina come la terminologia oscena, e i neologismi fascisti, di cui Mussolini pare che fosse particolarmente orgoglioso inventore, una volta che si compiacque di citare quest’opera che li aveva registrati con scrupolo accademico.
Provincialismo e sciovinismo culturale, sensualità mal repressa, pedanteria puristica, timor panico delle idee, dall’estetica di Croce alla politica di Lenin, fanno di quest’opera panziniana veramente un classico della cultura reazionaria che con tanto lievito di spiritosaggini ha conformato milioni di cervelli della piccola borghesia italiana. Da questo punto di vista il Panzini è certo da prendere sul serio. Molto più sul serio, che non le secrezioni sentimentali di cui la sua prosa inargentò pagine e pagine: contenta ai comodi che Dio le fece, chioccioletta davvero esemplare dell’umanesimo strapaesano.”- Log in to post comments