Submitted by admin on
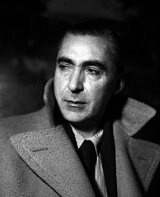
Curzio Malaparte
Nel celebre Italia barbara di Curzio Malaparte (1898 – 1957), c’è spazio, una decina di pagine circa, anche per Alfredo Panzini. Non poteva essere altrimenti essendo la sua opera “quasi la maschera della crisi o trasformazione (o commedia) dello spirito nazionale” alle prese con gli sconvolgimenti sociali ed economici del Novecento.
“Questo buon italiano che non sa decidersi a diventare moderno” mette in scena, nella parte del cronista stupito e disorientato, il crollo della tradizione e dei valori, la patria, la cultura (umanistica), “l’altare domestico”, che avevano educato e guidato l’anima degli antenati. Depresso e avvilito, Panzini risponde allo sfascio delle sue credenze tramite l’arma dell’ironia che addolcisce, ma solo in apparenza, il suo scacco esistenziale.
Malaparte legge nel malessere di Panzini il dramma dell’ultima generazione pre-moderna, confusa, immobile e sconsolata.
“E qui potrei provarmi anch’io, per entrare direttamente in materia, a dare una definizione approssimativa dell’uomo Panzini, con la speranza di agevolare a me stesso e agli altri la comprensione della sua maniera letteraria; ma preferisco, per timore di equivoci, e di responsabilità, fermarmi a quella, che di lui ha detto Antonio Baldini, chiamandolo «una specie di Parini che si scandalizza di tutto specialmente perchè bada a tutto». Trascurando il riavvicinamento all’autore del Giorno, che rientra in quel genere di subdoli accostamenti molto cari al Baldini (il quale ha fama, né bene se ne conoscono le ragioni, di arguto umanista), non è chi non veda come in quel suo badare a tutto e in quel suo conseguente scandalizzarsi di tutto sia contenuto il motivo principale, se non unico, dell’humor di Alfredo Panzini. Motivo senza dubbio sommamente drammatico, per chi consideri l'umorismo, come io sono portato a fare, una specie di commedia nella quale l’umorista è attore, e insieme provocatore e responsabile delle innumerevoli e ingarbugliate vicende che non gli danno pace, e che finiscono quasi sempre, dopo averlo fatto meravigliare di tutto, col dargli l’improvviso e tedioso stupore di se stesso.
Ora, quel che fa di Panzini un italiano in sommo grado rappresentativo tra i contemporanei e quasi la maschera della crisi o trasformazione (o commedia) che il nostro comune spirito nazionale oggi attraversa, è appunto questo motivo drammaticissimo dello stupore, il quale assume in lui, attore-tipo, gli aspetti più diversi e significatici. Io non so se Panzini si accorga di ciò ch’egli rappresenta e, più esattamente, della sua qualità di dramatis persona, ma ho ragione di credere che ciò non gli sia ignoto né gli dispiaccia, sebbene egli stesso m’abbia più volte dichiarato di non sentirsi, in presenza del compassionevole spettacolo che i nostri contemporanei stanno dando di se medesimi, del tutto italiano e tanto meno; cioè, in altre parole, di sentirsi più spettatore appartato che attore. Poiché mi sembra che Panzini rappresenti, in modo singolarmente fedele, la parte, comunissima alla maggioranza dei conterranei, del provinciale e del borghese che si meravigliano di tutto, che guardano ogni cosa a bocca aperta, che vanno dietro ai frulli, agli scodinzolamenti, alle illuminazioni, novità e incongruenze della vita moderna, senza capire il perché di tante cose mutate e senza conoscerne il segreto meccanismo, stupiti e insieme dispiacenti di non sentirsi moderni e di serbare ancora nei modi di una certa goffaggine che sa di paese tranquillo, di farmacia e di lume a petrolio.
Si badi ch’io non intendo, attribuendo la parte del provinciale e del borghese, far cosa che a Panzini possa sembrare irriverente: ho un concetto troppo onesto dell’invidiabile qualità borghese e di provinciale per attribuirla, specie nei riguardi di un esempio così decoroso, a titolo di canzonatura.
Poiché questo simpaticissimo italiano che viaggia indaffarato da una cosa all’altra, da un aspetto all’altro, per lui nuovo e sorprendente, di questa turbinosa e spregiudicata modernità oltremontana, tuttora in via d’innescamento sul tronco borraccinoso della nostra pesante e grassoccia sensibilità di nazione demodee; questo buon italiano che sa decidersi a diventare moderno e a dimenticare la grande casa patriarcale, piena d’ombra e di silenzio, la scansia dei vecchi libri, i ritratti dei nonni e l’altarino domestico con gli idoli del Risorgimento, le buone parole lette o ascoltate quando l’Italia era una grande provincia, o l’immutabile cerchio di cielo intorno al paese dei padri, con sòpravi disegnati i soliti cipressi e i pini e le chiesuole inaspettate; questo italiano nato da una razza che oggi sta per morire dopo aver assistito al disfacimento di tutto il mondo e all’invigliacchirsi di una tradizione che non mancava di bei gesti; questo incorreggibile italiano che, vedendo con tristezza i mutamenti e udendo parole nuove e leggiere, senza radici nel suo passato, finisce col meravigliarsi dell’imprevisto e del nuovo e quasi col vergognandosene, e non volendo sentirsi mutato e moderno finisce col non credere più a nulla, nemmeno agli antichi valori; questo buon italiano, dico, qualunque sia il giudizio che i contemporanei danno del suo modo di osservare e di meravigliarsi, cioè della sua arte, è senza dubbio un vero italiano, di quelli che hanno una tradizione e che la sanno difendere, di quelli, insomma, ai la nostra spregiudicata irriverenza di girini, in via di metamorfosi dall’antico al moderno, dovrebbe rispetto e quasi una segreta riconoscenza.
Questo modo di rappresentare l’incertezza e lo smarrimento del comune spirito nazionale, rimasto profondamente provinciale e borghese, quarantottesco, di fronte al nuovo spirito moderno, si manifesta in Panzini congiunto a una specie di umore profetico, che è proprio del moralista e del pedagogo. Il quale umore, se gli ha valso quel certo avvicinamento al Parini, non è però di tal natura da risparmiargli la sorte comune al gran numero d’italiani che egli rappresenta: e cioè un avvilimento inesorabile e progressivo. Le cronache degli ultimi cinquant’anni son piene di esempi appropriati. Poiché l’insoddisfatta curiosità di tutto, alimentata da una segreta preoccupazione didascalica, di cui il Panzini dà prova, non può condurre se non allo stupore fisso del Innocenza, la quale, per usare un termine nostrano men riguardoso di quello russo, ha tra noi voce di imbecillità. Non è chi non veda come io non intenda, con questo, recare offesa a Panzini (e ognuno se ne renderà meglio ragione in seguito) e nemmeno attribuirgli la parte di attore sfortunato preso e travolto nelle vicende dell’ingarbugliata commedia dell’umorismo, e ucciso, all’ultima scena, dal coltello di latta di un feroce suggeritore, quale io non mi sento d'essere. Ho anzi una fiera persuasione, a detta di alcuni forse ingiustificata, che Panzini finirà col prendere in uggia, tanto le raffinatezze estetiche dei parrucchieri in voga quanto i casi pietosi di Misiano, uomo moderno, i rifacimenti storici quanto la volontà umiliatrice del socialismo nostrano e le sue cialtronerie, le cronache italiane dei panni sporchi lavati in casa d’altri quanto ciò che fra noi sa di meschino e di peletto pudico, tutti soggetti, questi, cari al Panzini degli ultimi anni; e che lascerà al gran numero d’italiani, ch’egli ha fin qui rappresentato, la grave cura di meravigliarsi fino al limite del possibile, cioè fino all’imbecillità.Questa mia fiera persuasione è confortata dal fatto, che i segni dell’incipiente torpore appaion già manifesti sugli innumerevoli visi che ci attorniano, i quali, non senza una nostra gioia maligna, mostrano già a meravigliarsi anche di noi. Non credo che il progressivo intorpidimento degli italiani, e son parecchi, sia materia di riso e di soddisfazione a Panzini, che è un italiano di buona razza ed ha serbato in bocca, non ostante le molte orzate bevute in città, l'aspro sapore della, terra romagnola. Quel che gl’impedisce d’esserne contento è l'alto concetto ch'egli ha delle tradizioni e della razza, ma che noi, uomini quasi nuovi, uomini quasi moderni, non abbiamo o mostriamo di non avere. Certo, noi non abbiamo fra i denti sapor di terra, se non quello amaro che ci è rimasto delle buche e dei fossi tremendi delle Venezie; ma il buon sapore. della terra buona, dì quella che sa già di pane, noi non lo conosciamo; e quasi ci sembra, di esserci creati da noi stessi in questi ultimi anni, di non aver razza, di non essere antichi. In questo sentimento, forse, è la ragione della nostra gioia maligna, di fronte all’inesorabile e progressivo intorpidimento delle generazioni che ci hanno visto nascere. Che non soffriamo è naturale ed umano, e risponde forse a una nostra torbida comprensione della falsità, la quale ci ripaga in tal modo di tutto ciò che quelle generazioni hanno mal fatto o non hanno saputo fare in quarant’anni di pietose cronache nazionali.Ma il sentirsi antico, in Panzini, genera tristezza. Ciò lo salva da quell’ultimo stupore al quale il comune spirito è da tempo avviato, e gli darà modo di risentirsi solo, come quando c’era ancora in lui molto del buon contadino romagnolo, che, parlando, sorride per non dover bestemmiare e trova una giustificazione di tutto nel fondo immobile della propria antichissima tristezza.”
- Log in to post comments