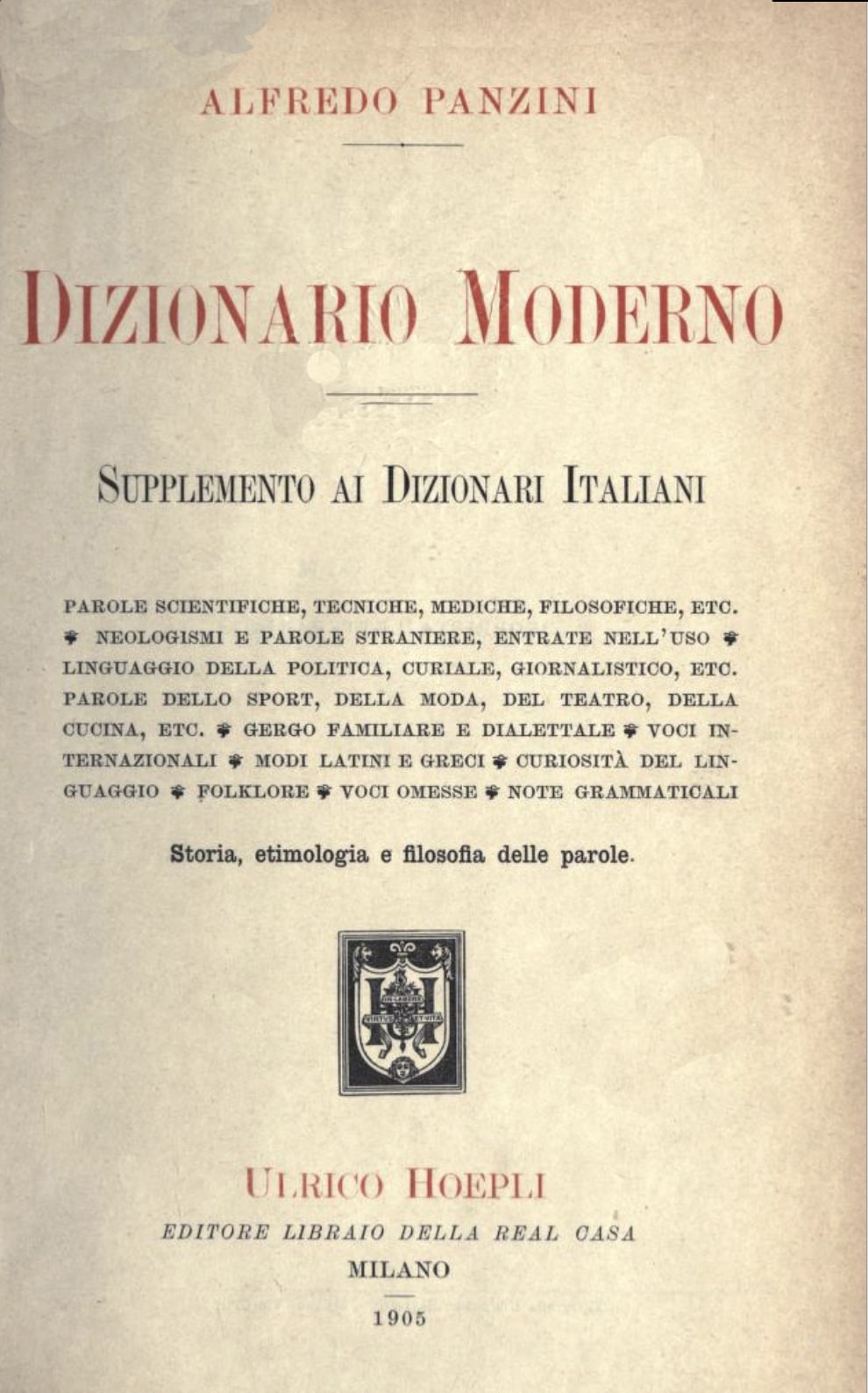“Alfredo Panzini, il brillante e fluido scrittore di prosa i cui libri non si capisce mai se siano romanzi, viaggi immaginari, saggi o pamphlet, ha recentemente pubblicato una guida grammaticale. Il libro si chiama Guida alla Gramatica italiana, edito da Bemporad di Firenze. Come si vede, la grammatica non rimane sempre e solo oggetto di studio di accademici e seminari filologici”.
Di chi sono queste riflessioni, che risalgono al 26 febbraio 1933 ed escono su un giornale culturale diretto da Nae Ionescu che si chiama «Cuvântul»? Sono del ventiseienne Mircea Eliade, non ancora il grande storico delle religioni che sarebbe diventato, antropologo, filosofo e saggista, ma già lanciatissimo col suo primo romanzo La notte bengalese. Aveva anche già viaggiato in India e poi, nel 1934, comincerà a insegnare filosofia all’università di Bucarest, per approdare in seguito all’École, alla Sorbona e in altre università europee, fino a Chicago dal 1957. A sedici anni leggeva perfettamente l’italiano che aveva imparato per attingere al suo faro intellettuale, Giovanni Papini, e divorarne i libri, e poi per leggere Panzini, gli orientalisti e storici delle religioni come Pettazzoni, Buonaiuti e Giuseppe Tucci.
Le righe che costituiscono l’incipit di questo articolo sono estrapolate da uno dei quattro articoli che Eliade dedica a Panzini tra il 1927 e il 1934 (sfuggiti alla critica panziniana fino al 2023) e s’intitola Gramatică. Costituiva la recensione alla Guida alla grammatica italiana che comparve in Italia nel 1933, preceduta l’anno prima dalla Piccola guida alla grammatica italiana.
Mircea Eliade proseguiva così: “Il libro di Panzini non è scritto nel rituale codificato delle grammatiche consolidate. Le definizioni che ci dà di “nome”, “soggetto”, “verbo”, non hanno la rigidità stereotipata dei libri di testo. Sono fresche di pensiero e, soprattutto, sono scritte bene come le più belle pagine de La lanterna di Diogene o del Padrone sono me!“. E aggiungeva: “Non c’è dubbio che solo un uomo che sa come scrivere può capire e parlare di grammatica. La grammatica non ha nulla a che fare con la scienza delle parole; appartiene alla scienza del pensiero. Solo uno scrittore con il senso della lingua, un artigiano della scrittura, può intuire perfettamente la grammatica. Gli altri, la imparano soltanto; e come la imparano, con quanta miseria e con quanto disgusto, ognuno se lo ricorda fin troppo bene dai tempi della scuola”.
Un linguista potrà rilevare in queste parole qualche eccesso, ma possiamo dire che contengono anche tanta sostanza su cui riflettere. Eliade ha colto come pochi altri l’originalità di Panzini, ed essendo un genio – anche se Panzini ci ha messo in guardia nel Dizionario Moderno dall’abuso di questo sostantivo: “La generosità con cui si regala il titolo di genio ha prodotto una specie di ribasso… nel titolo!” – ha illuminato anche campi nei quali non può essere ritenuto uno specialista.
È stato un grammatico “fuori ordinanza” Panzini. “Purus grammaticus, purus asinus”, ha scritto nel Dizionario Moderno: l’antica sentenza latina, “semplice grammatico, semplice asino”, seppure ispirata a una certa dose d’odio verso la categoria, “contiene molta verità”. Cosa intendeva dire? Che bisogna saper “vedere più in là delle leggi formali della grammatica”. Le “regole” sono argini, indicazioni della rotta da seguire, ma è dalla “servitù delle idee” che occorre guardarsi, visto che porta con sé, ha insegnato il prof. Panzini, anche la “servitù del vocabolo”. È una lezione ancora freschissima e a questo riguardo Mircea Eliade non andava affatto fuori tema nella sua recensione alla Grammatica.
Di Panzini e la lingua, con inserimenti di diversa natura, si parlerà nella seconda parte del convegno internazionale di Venezia il 18 e 19 dicembre nell’aula magna Trentin, Ca’ Dolfin, e un focus è previsto anche sul Dizionario Moderno (Ludovica Maconi e Matteo Grassano), per il quale una definizione giusta, pienamente esaustiva, non è stata ancora trovata. Certamente può essere considerato uno speciale termometro del Novecento.
È un’opera ciclopica e un caso più unico che raro nel panorama non solo italiano. L’originalità dell’approccio di Panzini anche ai temi linguistici è stata evidente. Un approccio non specialistico e con qualche risvolto che è stato oggetto di critica o stroncatura che dir si voglia (quella più nota porta la firma di Antonio Gramsci), ma il risultato è stato eccelso: una via di mezzo fra dizionario e enciclopedia, con l’inserimento di tutto un po’, voci antonomastiche, nomi propri, motti pubblicitari, proverbi, sigle, termini specialistici (giuridici, politici, economici, filosofici, gastronomici, militari, della grande guerra e così via) e di tanto altro.
È di una eterogeneità incredibile ma contiene i tratti distintivi di un intellettuale che riemerge dagli abissi della dimenticanza e, forse non a caso, proprio in questi anni. Gabriele Baldini ha scritto che “tutto quello che Panzini non è riuscito a ficcare nei libri, lo ha messo nel Dizionario”, ma non è un’accozzaglia assemblata senza un criterio. E il criterio è, appunto, Panzini stesso.
Giuseppe Mormino, uno dei critici più intelligenti dello scrittore della Casa Rossa, ha sostenuto che il Dizionario fa parte del “patrimonio umanistico” che Panzini ci ha lasciato, e che dunque possa diventare pienamente comprensibile solo dentro questo orizzonte.
Sul “purismo” di Panzini è stato scritto tantissimo ma per andare alla fonte occorre rileggere un testo che uscì in quattro puntate sulla Nuova Antologia nel 1933. Il titolo è Avventure di Signora Nostra Parola (la parola definita “signora nostra” è tutto un programma). Qui la scrittura di Panzini si è fatta velluto (e questo accade soprattutto all’incirca negli ultimi vent’anni della sua vita) e scorre ariosa e solenne come una musica di Verdi, la sua padronanza della materia lascia sbalorditi.
In Avventure di Signora Nostra Parola Panzini sostiene che la grammatica è un po’ come l’arte militare, sul campo di battaglia chi vince è il talento del condottiero ma la preparazione e la capacità di disporre gli eserciti non sono secondarie: “Si può vincere con milizie mercenarie e si può perdere con milizie nazionali. Si può scrivere bene usando parole forestiere, come si può scrivere male usando tutte parole nazionali. Questione di arte, arte militare e arte dello scrivere. La composizione dei suoni e dei colori nelle parole è fra le cose più delicate, come indovinare l’ora, il luogo, il momento per assalire il nemico. Che questa cosa avvenga per moto subitaneo di un Dio, cioè sine studio, senza grammatica, non implica che sia necessario il non studio, e la non grammatica”.
Potremmo dire che il grande amore linguistico di Panzini è stato un tutt’uno con quello per “signora nostra parola”.
Da Margherita Sarfatti Panzini è stato definito un “barometro di squisita sensibilità” per la sua capacità di leggere i cambiamenti epocali a tutti i livelli (linguaggio ma anche costume, politica, pensiero) e questo si comprende anche aprendo il Dizionario, che però è uno strumento difficile da maneggiare se tolto dalle mani di Panzini. Quando Bruno Migliorini e Alfredo Schiaffini curarono l’edizione postuma del 1942 questo problema si pose immediatamente perché attuarono una serie di “aggiustamenti”.
Precisarono che “il doveroso rispetto per la personalità dell’autore e un congenito senso storico ci hanno trattenuti dal ritoccare voci politiche invecchiate oppure chiose iconoclaste”. Nel primo caso (voci politiche invecchiate) il riferimento era al termine democristiano che Panzini inserisce nel Dizionario sin dalla prima edizione del 1905 alla voce democristiani o democristi, e secondo il Dizionario etimologico della lingua italiana Zanichelli, democristiano è attestato per la prima volta proprio da Panzini.
Ma si può ritenere una voce politica invecchiata? Scriveva Panzini: “…democristiano, neologismo, detto dei cattolici con tendenza socialista, o modernista, ma ossequienti alla volontà del pontefice”. Più che invecchiata è una definizione acutissima e descrive una tendenza talmente profonda che diventerà un’anima del partito della Democrazia cristiana in anni vicini a noi e darà vita ai governi delle convergenze parallele e poi di solidarietà nazionale.
A proposito delle “chiose iconoclaste” ci si può soffermare sul caso di “diritti dell’uomo” (“bella illusione del secolo XIX”, commenta Panzini) o sulla voce “binomio”: “per brutta estensione, in senso morale: il binomio libertà e giustizia, specchio per le allodole”. Probabilmente anche qui di superato e di iconoclasta c’è ben poco, e lo si comprende meglio oggi rispetto agli anni Quaranta perché nel frattempo la storia ha camminato e i “diritti dell’uomo” e il binomio “libertà e giustizia” abbiamo consapevolezza che spesso siano termini vuoti e niente più che specchietti per le allodole o miti della modernità direbbe Panzini.
Ma i due curatori del Dizionario in realtà se ne resero conto e annotarono che Panzini “si compiace di vivere in euritmia col tempo suo, salvi, beninteso, i numerosi e fortunati momenti in cui, agitante deo, supera la propria epoca”.
È davvero efficace questo “agitante deo, supera la propria epoca”. Ulteriore conferma di quanto aveva perfettamente intuito Margherita Sarfatti coniando il ritratto del “barometro di squisita sensibilità”.
Panzini è per un verso un uomo dell’800, nasce quattro anni dopo la seconda guerra d’Indipendenza, due anni dopo la proclamazione del Regno d’Italia, e quando muore Garibaldi nel 1882, è al termine dei suoi studi liceali al convitto Foscarini di Venezia, e quando apprende la notizia annota: “Era un giorno di gran sole ma ebbi la sensazione che il raggio del sole si oscurasse per sempre, e piansi dirottamente”. Ma questa è solo una “metà” di Panzini, l’altra è costituita dalla sua modernità, che gli ha consentito anche di comporre il Dizionario Moderno.
Panzini, allievo di Carducci, parla spesso della grammatica come caposaldo della lingua nazionale e riflette sul fatto che l’Italia unita senza una lingua nazionale, una lingua comune, non può dirsi nazione.
Qual è il problema, di una attualità incredibile: che per intendersi, per dialogare, occorre un linguaggio, un lessico, una grammatica, un insieme di strutture fissate che ci consentano di scrivere, parlare e intenderci. Siamo al cuore della grande questione che è al centro della filosofia del linguaggio. Non c’è solo l’io e non c’è solo il tu che intervengono nel processo di interlocuzione, ma il linguaggio stesso che ne rappresenta la dimensione istituzionale, nel senso che nessuno inventa il linguaggio, ma lo anima prendendo la parola in un contesto fissato da sistemi fonologici, lessicali, sintattici, stilistici eccetera.
Giuseppe Prezzolini ci ha fatto sapere di aver letto tutto il Dizionario al pari degli altri libri di Panzini e di essersi divertito molto perché in effetti può essere dissezionato da un linguista ma può essere goduto appieno anche da un non specialista, è un’opera da leggere, una panoramica storica delle cose dell’Italia e del mondo tra l’Otto e il Novecento. E proprio il suo essere non specialistico ha fatto sì che ottenesse un successo notevole presso un pubblico ampio (la preoccupazione ad occuparsi di cultura con un taglio “popolare” è stata costante in Panzini), come sarà per la Grammatica italiana ripubblicata da Sellerio negli anni Ottanta.
Panzini si schernisce quando gli rivolgono l’accusa di non aver mantenuto quell’imparzialità e integrità di giudizio che si convengono ad un compilatore di Dizionario, ma in realtà non può non essere se stesso nemmeno quando scrive questa sorta di “caravan serraglio” delle parole “senza domandar loro passaporto”, e si diverte a chiosare a modo suo e a divagare, a glossare umoristicamente. Si sforza anche nelle varie edizioni del Dizionario di asciugare gli interventi di commento, però senza riuscirci e probabilmente non vuole riuscirci. Dirà lui stesso la ragione: “…è difficile vincere la propria indole” e in fondo “di oggettivo poco v’è al mondo se non che due più due fanno quattro, ed anche di ciò non è certezza”. Ed è talmente consapevole di questo suo “limite” che in una lettera all’editore Formiggini, nel 1918, definisce il Dizionario Moderno oltre che una “fogna delle parole”, anche “un libro pieno di spropositi”. Sa ironizzare anche su se stesso Panzini, non solo sugli altri, e comunque quegli “spropositi”, spesso politicamente scorretti, sono fulminanti interpretazioni dei tempi:
Sedia elettrica: “la meno comoda delle sedie, benché a braccioli”. Nel Dizionario del 1905 aveva scritto “mezzo di barbarie moderna per dare la pena di morte legale (Stati Uniti)”.
Zio d’America: cioè l’apparizione provvidenziale nel vecchio mondo del parente fatto ricco nel mondo nuovo.
Terremotato: Anche le sventure generano i brutti neologismi.
Lotto: nel senso di lotteria, cioè di quella speculazione ufficiale che è denominata anche tassa sugli imbecilli.
Dabl-iusii: pronuncia all’inglese delle lettere W e C, iniziali di water (uoter) closet, il cesso. Vereconda espressione usata per far capire a pochi ciò che a tutti occorre.
Panzini e la modernità è il grande tema ancora aperto. Curioso del nuovo – dirà Sibilla Aleramo – ma assoluto demolitore del binomio modernità-progresso, che considera un mito cioè qualcosa di svincolato dalla razionalità storica, e da ascrivere piuttosto all’utopia delle ideologie. Panzini ritiene che tagliare le radici col passato equivalga a impoverire l’uomo; nel mutare dei tempi c’è qualcosa di immutabile da accogliere dal passato e da tramandare alle generazioni future.
Non inventa niente, certo, perché esprime solo quello che già l’antichità sapeva, cioè che al progresso tecnico materiale può corrispondere un regresso morale. Basterebbe andare con la memoria alle vulnera vitae di Lucrezio. Ma come ha riconosciuto bene Arnaldo Bocelli, in Panzini “il culto della tradizione non è disgiunto da un moderno sentire”.
A Panzini, come agli antichi piace coltivare il senso della contraddizione, ironizzare sulla vita, è cosciente dei limiti che sono propri dell’uomo in ogni tempo nel rapporto con gli altri uomini e con il mondo.
Matteo Grassano (Università di Bergamo), che sarà presente al convegno di Venezia soffermandosi su Panzini nella linguistica italiana tra Secondo Novecento e Terzo millennio, di recente ha pubblicato Nel turbinio delle parole. Lingua e riflessione linguistica in Alfredo Panzini (Biblion 2024) dedicandosi anche a “Pastiche e sperimentalismo linguistico nei romanzi di guerra”, passando in rassegna La Madonna di mamà e Il padrone sono me!, due opere spesso citate ma non conosciute.
Anche dal punto di vista linguistico Il padrone sono me! è un testo specialissimo e deve essere ancora valorizzato e posto in relazione con altri autori (pochissimi in verità) che hanno fatto qualcosa di simile a quello che ha fatto Panzini. La più “originale e sperimentale” opera di Panzini la definisce Grassano. A partire dalla sgrammaticatura del titolo, audace forzatura della grammatica per assegnare valore letterario all’universo linguistico popolare. È un aspetto ben noto ai contemporanei di Panzini: per Papini, ad esempio, “non è soltanto istruito ma colto e come tale sa stare anche col popolo e lo capisce”. Ma è ancora poco per definire Il padrone sono me!

Sempre Grassano precisa che Panzini ridisegna in questo romanzo “il paradigma dei pronomi personali”. E dentro questo ridisegno che cosa emerge? È la romagnolità la protagonista indiscussa.
Una analogia che viene quasi naturale a proposito della romagnolità che troviamo nel Padrone sono me! è con Amarcord di Federico Fellini, che tra l’altro ha letto sicuramente qualcosa di Panzini. In I clown, (a cura di Renzo Renzi, Cappelli 1970), Fellini annota: “Ho sotto gli occhi, tra le tante, una definizione del clown del mio conterraneo Alfredo Panzini, nel Dizionario moderno”, e riporta per intero la voce clown, che è uno dei tanti lemmi circensi che ci restituisce il Dizionario sin dal 1905.
Di certo il circo presente nel Dizionario era noto a Fellini ma forse anche altri testi, come la Lanterna di Diogene, con descrizioni delle pescivendole che sono particolarmente felliniane.
Nel Padrone sono me! svetta la figura dello strambo, ad esempio. Queste le ultime parole che chiudono Il padrone sono me!: “Era così stramba, la Dolly”. La vicinanza agli strambi di Fellini è fortissima.
Luigi Emery (giornalista bolognese e anche ottimo traduttore dal tedesco e che fu allievo di Panzini negli anni del ginnasio) recensì il Padrone sono me! sul Resto del Carlino e scrisse questa meravigliosa definizione: “Questo libro è come tradotto dal romagnolo; vi sono raccolte a piene mani frasi e parole della terra adriatica di Romagna; e ne è venuto fuori un linguaggio saporitissimo in cui si sente l’aroma del dialetto attraverso la buccia sottile e screpolata qua e là”.
Panzini ha voluto proprio utilizzare questo registro nel tracciare quel quadro storico, che è anche molto politico, che troviamo nel Padrone sono me!, e ha dato alla romagnolità dignità di caso letterario, ma Luigi Emery fu uno dei pochi a capirlo con piena lucidità.
Un altro particolarmente affascinato da Panzini fu Sergio Zavoli, che in un incontro pubblico alla Casa Rossa nel 2011 raccontò il suo legame profondo con Panzini: “Mi incuriosiva molto la lingua di Panzini, che ha scritto in un italiano di una bellezza inconfondibile. Trovo che il giudizio di Manara Valgimigli sia straordinariamente equo: Panzini è stato veramente un grande scrittore, non gli è stato dato nulla in più di quel che ha avuto, anzi, rimane in credito di tante cose. Uno scrittore così esercitava molto fascino su un giovane come me che aveva un po’ la pretesa di dedicarsi a programmi culturali e non soltanto del giro d’Italia, che pure è stata per me una bella e simpatica esperienza”.
Sarebbe anche molto interessante confrontare Il padrone sono me! con un altro caso celebre di romanzo segnato da una lingua intrisa di dialetto, cioè La malora di Beppe Fenoglio, che esce nel 1954: anche lì il protagonista è un giovane contadino, però nel contesto geografico delle Langhe, e vi scorgiamo dialoghi come questo: “me e te siamo due bei stupidi”.
“È evidente – ha notato Grassano – in Il padrone sono me! la ricerca di Panzini intorno all’italiano parlato dalle classi popolari, l’attenzione verso la lingua dell’uso, di cui si nutre la sua attività lessicografica relativa al Dizionario Moderno, e la lingua del Padrone sono me! colpisce ancora di più se si considera, con il senno di poi, il periodo di stesura del romanzo”, cioè il 1922.
[Il disegno d’apertura è di Amerigo Bartoli Natinguerra (1890 – 1971) pubblicato sulla “Gazzetta del Popolo” il 14 novembre 1934].
Panzini lessicografo: uno speciale termometro del Novecento